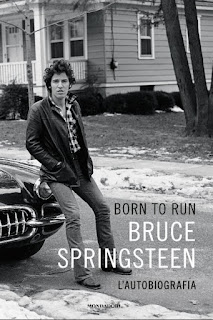Sondrio, dicembre 2013
Caro Bruce, i soliti bene informati dicono in giro che io sia un innamorato geloso, un rigido individualista, un nostalgico del tempo che fu. E, nonostante questo, uno comunque pronto a lacrimare come un vitello al tuo primo “one, two…”. Inoltre si vocifera, e posso confermartelo di buon grado, che io non abbia nessun titolo per poter in qualche modo suggerire qualcosa a una personalità artistica del tuo spessore. Quindi, questa lettera non conta un cazzo.
Questa premessa era dovuta, a scanso delle critiche che mi pioveranno addosso da parte di tanti tuoi fan. Critiche delle quali, a ben pensarci, non mi importa nulla.
Bene, lunedì 25 novembre 2013 è stata annunciata l’uscita di High Hopes, il 18esimo tuo disco in studio. Abbiamo appreso che si tratta di un disco che contiene 3 cover (per la prima volta nella tua carriera, escluso il progetto unico su Pete Seeger, pubblichi in un tuo album di studio delle cover e lo intitoli col titolo di una di queste), 2 canzoni già edite in versioni nuove, 7 canzoni inedite che sono in gran parte out takes dei dischi degli ultimi dieci anni. In pratica, scarti.
Questo annuncio mi ha mosso molte considerazioni, che coltivavo da tempo, e ho pensato di esplicitarle tutte, finalmente, su un foglio di carta. L’unico metodo che mi appartiene.
Sono passati meno di due anni dal tuo convincente album Wrecking Ball, e pochissimi mesi dalla fine di un tour multimiliardario, durato quasi due anni, che ha riempito stadi enormi in tutto il mondo e che in Europa è tornato, a volte addirittura nelle stesse città, più volte nell’arco di nemmeno un anno. Questo tour è stato il terzo di fila con la E Street Band, dopo le dolorose scomparse di Danny e Clarence via via allargata, dal 2007, quindi dai tuoi 58 anni, fino ad oggi, il periodo in cui ne hai compiuti 64. Ebbene, io ti seguo da quasi 25 anni e ne ho viste tante. Sono fra gli estimatori della stoica prima fase della tua carriera, anche se per questioni anagrafiche non l’ho potuta vivere in diretta. Sono stato fra quelli che hanno accettato l’arrivo dei sintetizzatori nel suono di Born in the Usa e Tunnel of Love. Sono stato fra quelli che hanno voluto capire lo scioglimento, per un lunghissimo periodo di 10 anni, della E Street Band, in tempi in cui eravate tutti ancora giovani e in salute. Sono stato fra quelli che hanno cercato e trovato il buono che c’è in Human Touch e Lucky Town, finto di non sentire le campane della chiesa abbattere come fucilate mortali la poesia di Real World, e persino costruito delle motivazioni plausibili per la scelta della band di dilettanti che mi hai piazzato davanti agli occhi in quel periodo. Sono stato fra coloro che hanno seguito tanti concerti del tuo lungo tour acustico per il capolavoro Tom Joad. Sono stato fra i più entusiasti seguaci del Reunion Tour, del Rising Tour e del secondo tour acustico della tua carriera. Ho adorato le Seeger Sessions e amato da subito anche il ritorno rock di Magic, album criticato dai molti che sostenevano vi imitassi quel te stesso che prima loro avevano rimpianto... Mi sono battuto contro tutti nell’impresa titanica di scovare le cose migliori di Working on a Dream e mi sono ritrovato felice di vivere tutto il periodo trionfale di Wrecking Ball. Ho giustificato senza timori, attribuendole alla casa discografica e non certo a te, qualche operazione commerciale discutibile come 18 Tracks, American Land Edition, Essential, raccolte di ogni genere, fino al recente, poco edificante, Springsteen & I, dove più che altro mi pare venga posta all’attenzione del mondo un’isterica e spesso triste idolatria. Ho rispettato la tua scelta di tornare al rock muscolare e non mollarlo più nonostante l’avanzare dell’età, la tua decisione di proseguire con i raduni di massa, il tuo desiderio di mostrarti ancora giovane e fisicamente prestante (come evidenzia in modo plateale anche la copertina del disco che sta per arrivare) di fronte a platee sterminate in cui via via sono apparse nuove entusiaste generazioni.
Ti sono rimasto sempre fedele perché ti voglio un bene infinito, ti stimo come artista e come uomo, sei stato e sei una parte determinante della mia vita.
Ma la notizia di questo nuovo album, di questo tipo di nuovo album, con un nuovo tour del tutto simile agli ultimi tre già ampiamente annunciato, mi ha suscitato più di una domanda.
Nel 2014 compirai 65 anni e, nei tuoi piani, c’è una nuova conquista degli stadi di tutto il mondo, delle ragazze danzanti nelle prime file, dei bambini sulle spalle di fanatici genitori, delle frizzanti nonnine incartapecorite e delle sterminate schiere di ammiratori di ogni forgia che nella fase avanzata della tua carriera sei riuscito addirittura a moltiplicare, portando a termine un’operazione davvero fuori dal comune.
Questa scelta però lascia parecchi dubbi ai seguaci di vecchia data, e non sarei un tuo onesto “amico” se non te lo dicessi, arrivati a questo punto. Questo disco, che non giudico perché non lo conosco e sono già certo che dopo l’ascolto lo considererò positivamente, è comunque senza nessun dubbio un minestrone di cover di band semisconosciute, di cose già note, di cose che in passato avevi bocciato. Questo è un fatto oggettivo. Il tutto condito dalla presenza di un chitarrista rap metal di cui nessuno dei tuoi vecchi seguaci capisce né la necessità, né l’affinità con la tua musica. L’album appare come la scusa buona per poter tornare a un nuovo tour greatest hits a ripetere incassi stratosferici sulla ridondante melodia della milionesima Hungry Heart. Sensazione che avemmo già con il trascurabile progetto Working on a Dream.
La domanda che i tuoi “fratelli” più anziani, per i quali credo di essermi guadagnato almeno il diritto di parlare, si fanno, è se non sarebbe il caso di invertire la tendenza. Il mondo, con la tua poetica rock, lo hai conquistato fin dagli anni ’80, la E Street Band, dopo lo scioglimento, l’hai fatta rivivere e l’hai regalata a tutti (a volte nella stessa famiglia a figli, genitori e genitori dei genitori), l’olimpo della star internazionale ti appartiene ormai da tempo. Non sarebbe allora il caso, passati i 60 anni, di cercare vie più epiche per rendere la tua carriera immortale? Non sarebbe il caso di misurare le uscite discografiche, di imboccare strade musicali meno battute, più di culto? Non sarebbe più in linea con la tua età e con la tua gloriosa storia abbandonare gli stadi e cominciare a suonare in posti più raccolti, per la gente che ti segue con passione sincera e non in base all’orecchiabilità dell’ultimo singolo? Lo hai già fatto in passato, paradossalmente in età più verde, e non lo fai più ora che forse sarebbe più naturale farlo… Altri grandi artisti della tua generazione lo hanno fatto con ottimi riscontri. Molti, non certo tu, fra quelli che invece si sono ostinati nel perpetrare la strada della gloria passata sono diventati delle brutte copie di se stessi.
Ti faccio un esempio extra musicale che secondo il mio parere è sintomatico. Pensiamo a Clint Eastwood. La stragrande maggioranza dei suoi capolavori alla regia sono venuti dopo il compimento dei 60 anni di età. Nei 20 anni fra i 62 e gli 82 ha regalato pagine di storia del cinema, partendo con “Gli spietati”. E non lo ha mai fatto rincorrendo il successo del botteghino. Non ha mai rifatto Callaghan, anche se questo gli avrebbe garantito nuovi debordanti successi commerciali. Ma ha diretto film che rimarranno indelebilmente impressi nella memoria collettiva, come “Gran Torino”. E lo sta ancora facendo. La conferma di quel che affermo mi è venuta, con dati di incasso oggettivi, dalla recente lettura del libro “Clint Eastwood. Un ribelle americano” di Marc Eliot.
La mia domanda è: cosa potresti dare tu alla storia della musica folk, country, blues, swing, gospel ed ancora rock (seppur magari in versione più asciutta e meno pomposa), se nei prossimi vent’anni seguissi il suo esempio? Ho sempre visto delle affinità, anche se non politiche, nel modo di fare arte, in voi.
Le tue scelte molto popolari degli ultimi anni a cosa hanno portato? Ci hai mai pensato davvero? Al di là degli incassi, dei quali non credo che, dopo un certo tempo, tu ti sia mai interessato molto, e dei quali certamente hanno potuto godere le centinaia di persone che gravitano nel tuo staff e nel tuo mondo, al di là dell’esposizione mediatica, al di là dei momenti memorabili che ci regali e del divertimento che provi ancora a stare sul palco ogni sera coi tuoi amici - in modo superlativo - per più di tre ore, il risultato principale è stato quello di far conoscere te e la tua musica ai giovani. Sicuramente questo fatto può essere considerato positivamente. Ma sarebbe miope considerarlo solo positivamente.
Hai mai pensato a quanta gente che ti seguiva in passato stai oggi perdendo? Quelli che, senza Internet, senza voli low cost, senza telefonini, senza braccialetti, senza pit, prendevano le loro macchine scassate negli anni ’70 e ‘80 per raggiungerti in un unico concerto, dopo 10 ore di strada, perché per loro era l’evento di una vita, era una cosa attesa per anni, era la sola e rarissima occasione di porsi in contatto con i loro sogni. Quelli che saltavano su un treno dalla più sperduta casa di provincia per raggiungere la città dove, in uno scantinato maleodorante, proiettavano clandestinamente un video rubato del tour di Darkness. Quelli che spendevano buona parte del loro stipendio in bootleg. Quelli che facevano arrivare fanzine da ogni angolo del mondo perché era il solo modo di avere qualche timida notizia sul tuo attesissimo e segretissimo nuovo album. Quelli che parlavano di te agli amici con la venerazione che si riserva agli dei, e faticavano a comprare dischi di altra gente, perché gli sembrava di tradirti. Io queste persone le ho conosciute quando ero un neofita, mi sono ispirato a loro perché mi sono capito loro simile e le ho prese ad esempio di vita. Mi hanno indicato la via, ed è stata la via giusta. La tua via.
Beh, Bruce, negli stadi di oggi, molta di quella gente comincia a mancare. Certo, perché i tempi sono cambiati. Certo, perché sono invecchiati. Ma anche perché i tuoi nuovi fan, quelli che hai cresciuto con Radio Nowhere (per altro bellissima) - e speriamo resistano al primo album scarno ed essenziale - sono di matrice diversa, forse migliore, ma diversa. Sono figli di questi tempi. Organizzano file di giorni interi per essere sempre davanti a te. E loro, quei vecchietti di cui dicevo, che oggi lavorano tutta la settimana e magari hanno figli da mantenere, non possono perdere giornate per mettersi in coda agli ordini delle nuove leve. E alla fine, per vederti solo da distante, se ne stanno sul fondo, oppure rinunciano, sopraffatti dall’ondata dei nuovi fan e stanchi di non sentire più quella magia. Cominciano a mancare perché non si riconoscono nella nuova gente che hai attratto. Cominciano a mancare perché sperano in un disco sporco e minimalista, misantropo, incazzato, che non piaccia a tutti, che non venga messo in radio, che non faccia sorridere ebete la fanciulla in canotta sulle spalle del fidanzato.
Capisco che questo ragionamento vada contro ogni logica commerciale, ma all’età che hai brillantemente raggiunto, deve essere davvero ancora così importante per te, l’ambito commerciale?
Ora, Bruce, io ci sono sempre stato e ci sarò ancora, e in ogni caso il 15 gennaio - non ascolto certo i tuoi dischi prima dell’uscita ufficiale - sarò il primo a dire che, tutto sommato, hai piazzato un altro bel disco. E ti difenderò se qualcuno ti attaccherà, come ho sempre fatto. Però il mio invito, se mi posso permettere, è di prendere in considerazione anche questa faccia della medaglia. Hai ancora tanto tempo davanti e troppo talento per permetterti di non regalarci perle che potrebbero restare immortali. Perle da poter paragonare a Nebraska senza arrossire, aderenti alla tua attuale età, e in linea con quella vecchia promessa che fino ad ora hai sempre saputo mantenere. Loro, i vecchi seguaci, aspettano quello. Noi aspettiamo quello. Queste sono le nostre ‘grandi speranze’ riguardo te e la tua musica per questo 2014 e per il futuro.
Ma alla fine hanno ragione quei bene informati che dicono in giro che io sia solo un innamorato rabbioso e antiquato, che ti vorrebbe tutto per sé e per un èlite di privilegiati da lui stesso scelti dopo marziale selezione. Un estremista egoista e crudele che non ama le masse e non capisce la condivisione, e quindi questa lettera non conta proprio un cazzo. Mi spiace persino di avertela scritta, perché temo potrebbe in qualche modo ferire la tua sensibilità. E non potrei sopportarlo. E non voglio che la legga nessuno, perché queste cose devono restare fra noi. In pratica, dimenticala subito e buttala nel cesso.
Scusami, e buon Natale.